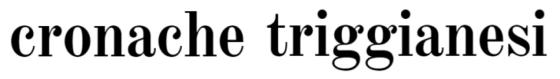di R. Fiore
La notte del 22 maggio 1970 l’appuntato Giuseppe Ciccone, in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Triggiano, se la sarebbe ricordata per il resto della sua vita.
Percorreva le strade buie e silenziose de paese durante il suo turno di pattuglia, quando all’improvviso scorse nei pressi della Villa un uomo in evidente stato confusionale, con i vestiti sporchi di sangue che si avvicinava verso di lui. «So’ fatt a frttat!», disse quell’uomo misterioso al carabiniere: il suo sguardo era inquietante, gli occhi sbarrati, le mani tremanti portate ad una ferita sanguinante al basso ventre.
«Chi sei, cosa hai fatto?», domandò preoccupato l’appuntato Ciccone, capendo che non si trattava di un semplice ubriaco vagabondo, ma che quel suo turno di pattuglia si sarebbe concluso con di qualcosa di molto più grave. «Sono Raffaele Di Gregorio», rispose l’uomo, che a fatica riusciva a mantenere un contatto con la realtà: «so’ accis migghierm e tre figgh che n’accett».
No, non era il solito turno di pattuglia. Ciccone fa salire l’uomo in macchina – «stai calmo, adesso ti chiamo un medico e ci racconti tutto» – lo rassicura, mentre Di Gregorio continua a biascicare frasi confuse e prive di senso. I militari, tradotto l’uomo in caserma, raggiungono subito la casa del Di Gregorio nel cuore della notte: si tratta di un interrato (una volta si diceva «sottano») di un edificio a due piani in via Dante, a fianco dell’ingresso dell’Ospedale Fallacara. La scena che si presenta ai carabinieri sembra uscita da un libro dello scrittore di gialli polizieschi Giorgio Scerbanenco, molto famoso proprio in quegli anni.
La casa è quella tipica dei contadini di Triggiano: piccola e umile, con i suoi pochi mobili dove in una sola stanza si dormiva in cinque e più persone. Gente semplice, abituato a scandire la propria esistenza e il proprio lavoro dal ritmo immutabile ed eterno delle stagioni.
Pian piano si faranno chiari i contorni e la dinamica, grazie ai rilievi condotti dai militari e alle ricostruzioni dell’uomo: Di Gregorio si sveglia nel cuore della notte mentre tutti dormivano in un sonno profondo, si reca nell’angolino della casa dove ci sono tutti i suoi attrezzi da lavoro, prende la scure e colpisce a morte sua moglie Maria Morisco di 36 anni. Dopo quegli attimi di delirio l’uomo si siede, forse sopraffatto da quell’orrore, quindi si reca dai figli: Michele (6 anni) e Lucia (4 anni) muoiono subito nel sonno sotto i colpi folli del padre; a quel punto la più grande, Cosima (8 anni), si sveglia e cerca di fuggire ma il padre la riduce al silenzio con una calza in bocca prima di riservagli la stessa orrenda fine toccata agli altri membri della famiglia.
Tutto, fra quelle quattro mura umide e ricoperte di sangue, è nel disordine più completo e racconta la drammaticità della strage avvenuta poche ore prima. Quei corpi sono immobili e straziati dai colpi, il silenzio notturno è inquietante; mentre cammina fra le chiazze di sangue l’appuntato Ciccone si starà chiedendo se tutto quell’orrore sia reale o frutto di un incubo. Sul tavolo viene rinvenuto un biglietto scritto da Di Gregorio: «Ho ammazzato mia moglie per motivi di gelosia: essa tradiva. Ho ammazzato anche i bambini per non lasciarli soli». Era il biglietto d’addio scritto dall’uomo il quale avrebbe voluto suicidarsi subito dopo: in realtà riuscì a procurarsi solo una ferita al basso ventre, prima di uscire di casa in stato confusionale ed essere fermato dall’appuntato Ciccone.
Nulla lasciava presagire questa strage: la coppia era sposata da dodici anni, la sera prima avevano tranquillamente visto la televisione con l’amico Alessandro Tatone. Probabile che la mente malata di Di Gregorio stesse da tempo elaborando deliranti pensieri e ossessioni di gelosia, che poi sarebbe esplosi in un atto forsennato nel cuore della notte, quando neppure i vicini hanno sentito nulla poiché le vittime sono state colte nel sonno. L’assassino finì i suoi giorni presso il manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto (in provincia di Messina) dove, si dice, finì per suicidarsi impiccandosi.
Un quarto figlio della coppia, Lorenzo, 11 anni, per puro caso scampò alla strage: si trovava in collegio e sarebbe dovuto ritornare in casa qualche giorno dopo. Quel bimbo, diventato grande, a Triggiano iniziò ad essere chiamato da tutti “Celentano” perché amava canticchiare ad ogni occasione le canzoni del molleggiato.
Personaggi triggianesi, Storia triggianese
1970, strage a Triggiano: uomo uccide la moglie e tre figli